|
22/07/17.
Archeoclub: Progetto per la fruizione
della Strada Romana nella Corte
delle Stelle
Sabato 22 luglio, alle 18.00, nella Sala delle Capriate del Palazzo di Città a Cefalù, sarà presentato
al pubblico il progetto di valorizzazione e fruizione del sito archeologico, interno all’edificio
“Corte delle Stelle”, costituito da un tratto di “Strada romana” risalente al I sec. d. C. Seguirà alle
19.30 la cerimonia d’inaugurazione dell’itinerario nei locali del sito in corso Ruggero, 94.
Il progetto si è concretizzato attraverso una convenzione stipulata - lo scorso mese di aprile - tra
l’Archeoclub d’Italia onlus e il Comune di Cefalù, proprietario del sito.
La sede di Cefalù dell’Archeoclub d’Italia, che da vent’anni si occupa di far conoscere e far fruire –
in modo corretto e consapevole – i beni artistici e i luoghi della cultura della città e del territorio, si
fa carico di rendere fruibile il sito attraverso l’attività di volontariato dei propri Soci e attraverso la
collocazione di alcuni pannelli didattici nell’area antistante l’ingresso della saletta archeologica.
I
testi contenuti nei pannelli esplicativi all’interno del sito sono stati elaborati dal prof. Marcello
Panzarella, progettista dell’edificio e dal prof. Amedeo Tullio, archeologo responsabile dello scavo
e curatore scientifico del progetto di fruizione. Inoltre, l’Archeoclub d’Italia ha chiesto alla
Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Palermo la di poter esporre, all’interno della saletta
archeologica, i reperti relativi alle infrastrutture urbane connesse alla strada, al fine di rendere
ancora più leggibile e chiaro il sistema tecnologico delle reti di sottosuolo, fognaria e di
approvvigionamento idrico del tempo. Alla richiesta è seguito il nulla osta della Soprintendenza,
che consente di poter esporre - in sicurezza e con un costante servizio di custodia durante gli orari
d’apertura al pubblico - i reperti mobili relativi alla strada, che attualmente si trovano custoditi nei
depositi di Capo Marchiafava a Cefalù.
Il progetto prevede una implementazione dei pannelli didattici per la conoscenza degli altri siti
archeologici della città, in modo che la “Corte delle Stelle” divenga il punto di partenza di un
“itinerario archeologico cittadino”. Ciò sarà possibile, in parte e in tempi relativamente brevi, grazie
al sostegno concreto del Rotary Club di Cefalù e del Lions Club di Cefalù. I due Club Service,
infatti, condividono e sostengono pienamente l’iniziativa, che ritengono importante per le ricadute
culturali e sociali all’interno della comunità locale.
La sede di Cefalù dell’Archeoclub d’Italia onlus, movimento di opinione pubblica al
servizio dei beni culturali e ambientali, ente morale riconosciuto con d.p.r. n.565/86, rivolge la
propria attività di volontariato per la fruizione del sito a tutti i visitatori e in particolar modo ai
giovani e agli studenti delle nostre e di tutte le scuole.
Dal 27 luglio al 31 agosto prossimo il sito sarà aperto ai visitatori nelle giornate di giovedì e
sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 18.00 alle 20.00, con ingresso gratuito.
Fortunata Flora Rizzo (Presidente
Archeoclub Cefalù)
|
|
AUDIO
1:
00'
Sindaco Rosario Lapunzina; 06'
40
Daniele Tumminello, V.Presidente
Consiglio; 11'
15
Assessore Vincezo Garbo; 15'30
Flora Rizzo, Presidente Archeoclub
Cefalù;
AUDIO
2:
Intervento
Prof. MARCELLO PANZARELLA
AUDIO
3:
Intervento Prof. AMEDEO TULLIO
|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|
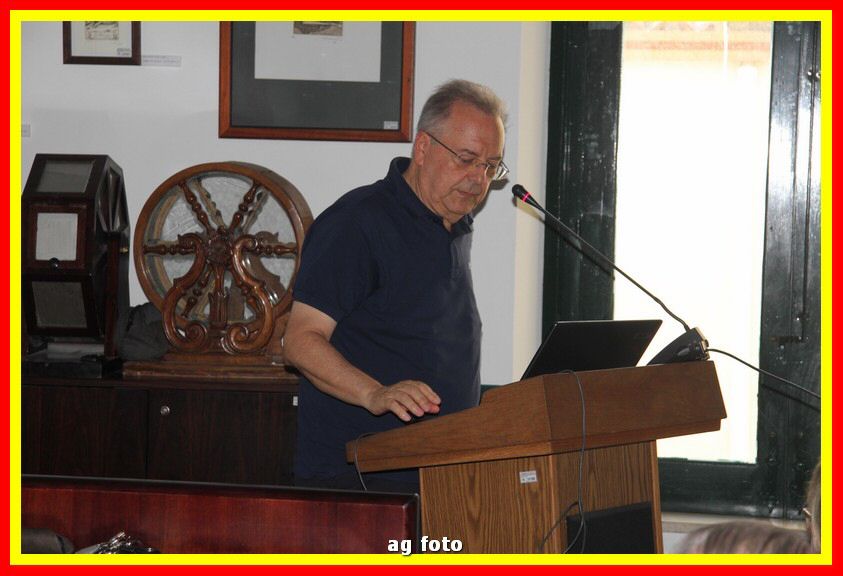
|
|

|
|

|
|
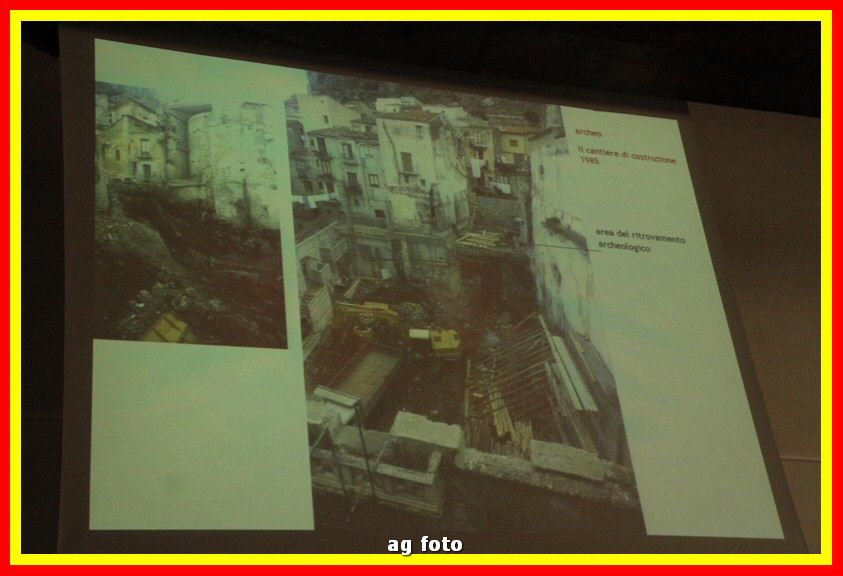
|
|
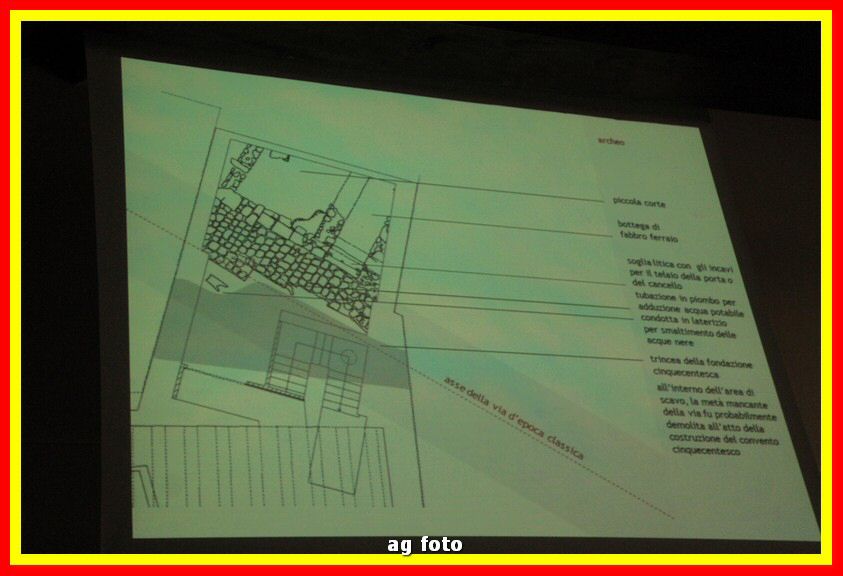
|
|
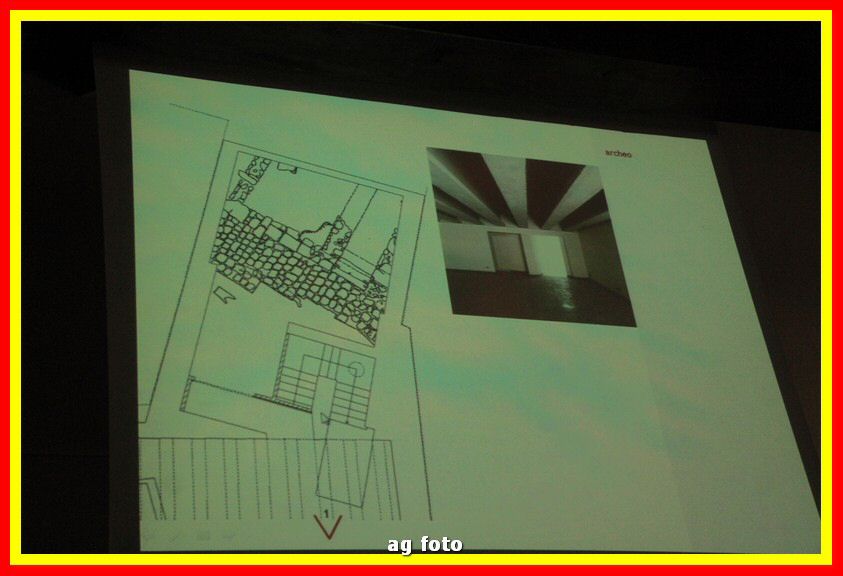
|
|
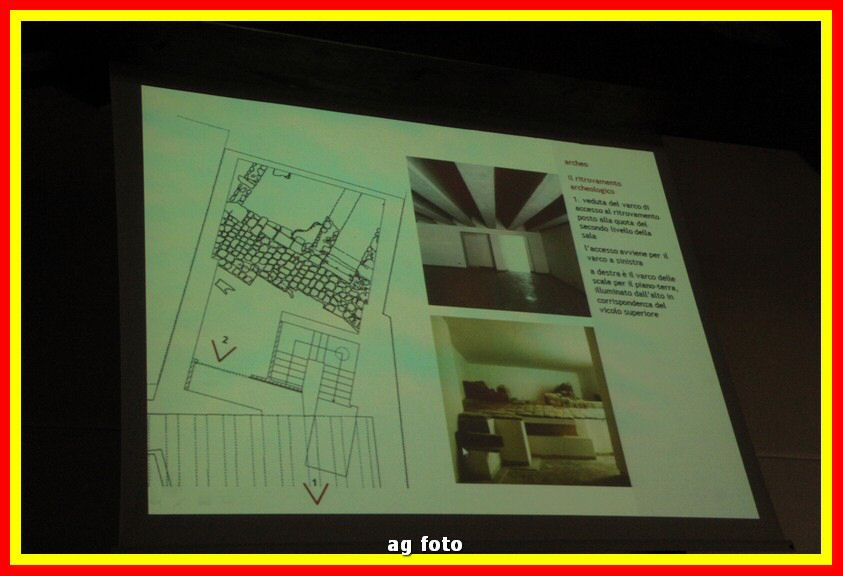
|
|
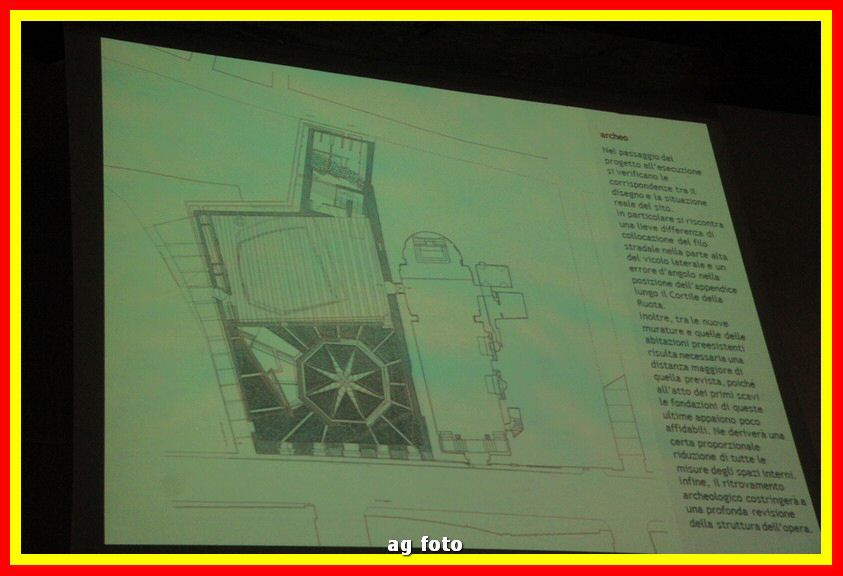
|
|
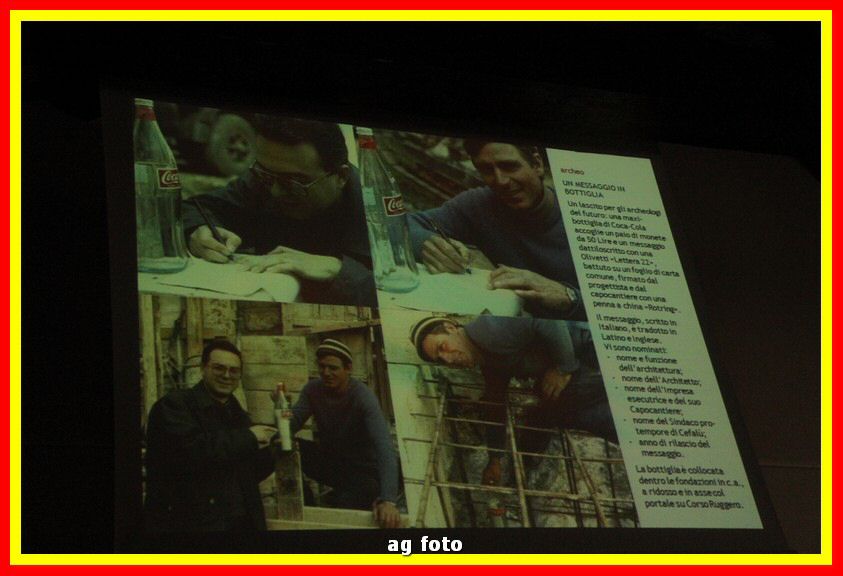
|
|
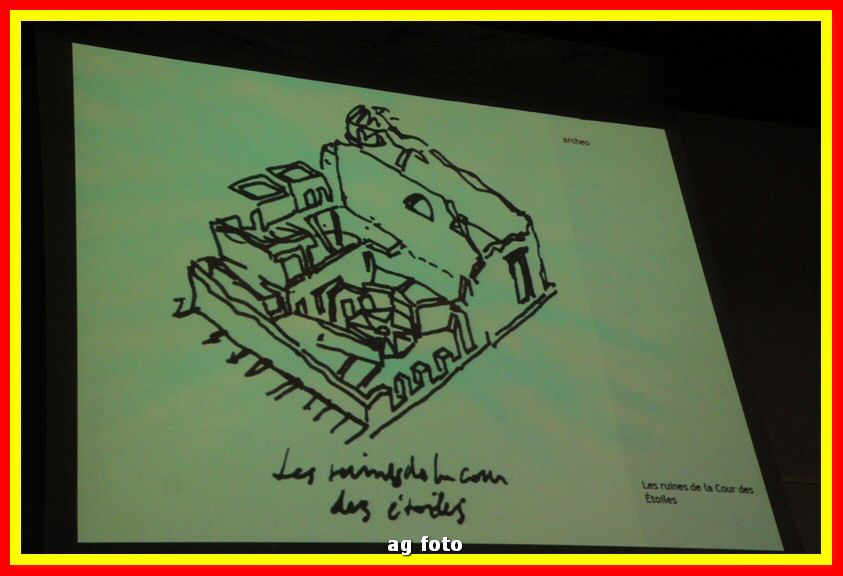
|
|
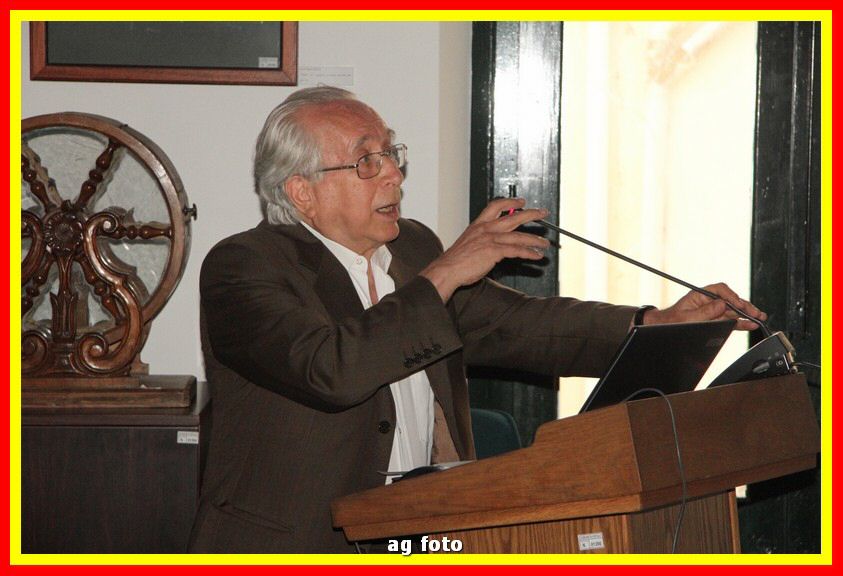
|
|
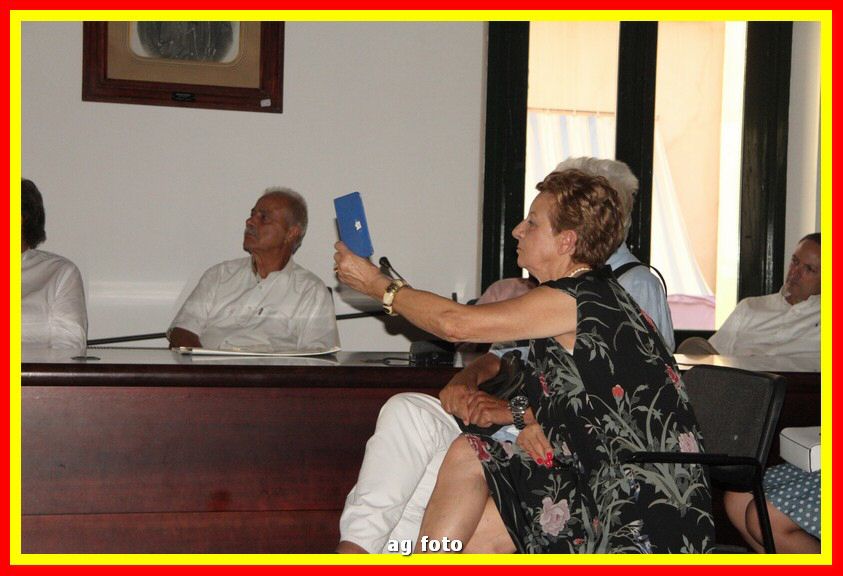
|
|
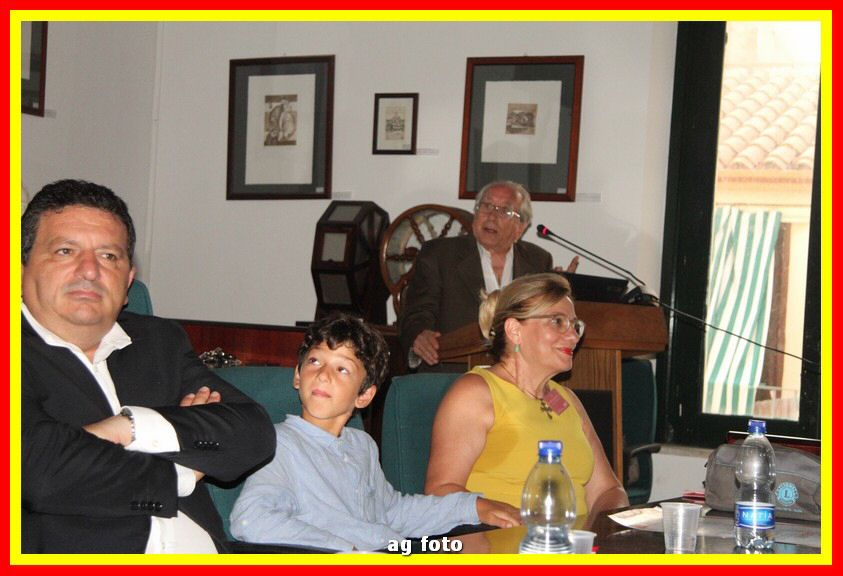
|
|
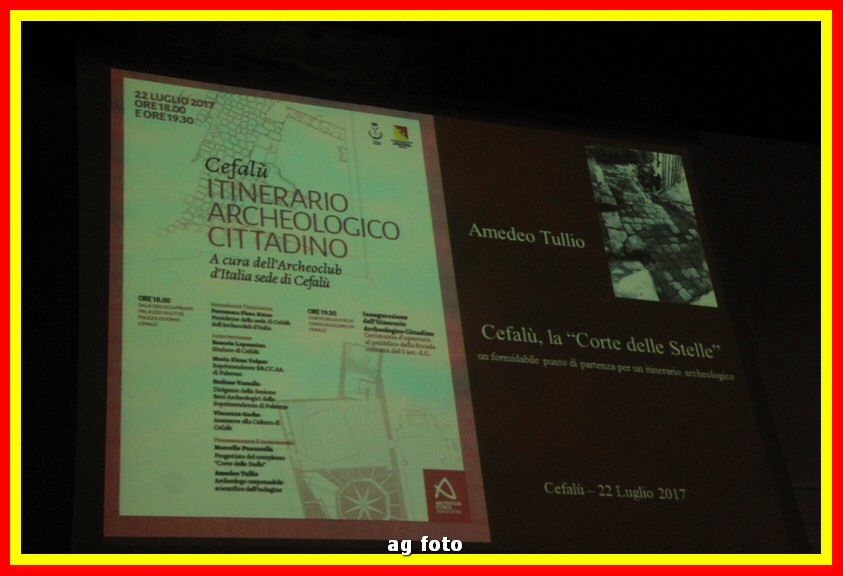
|
|

|
|
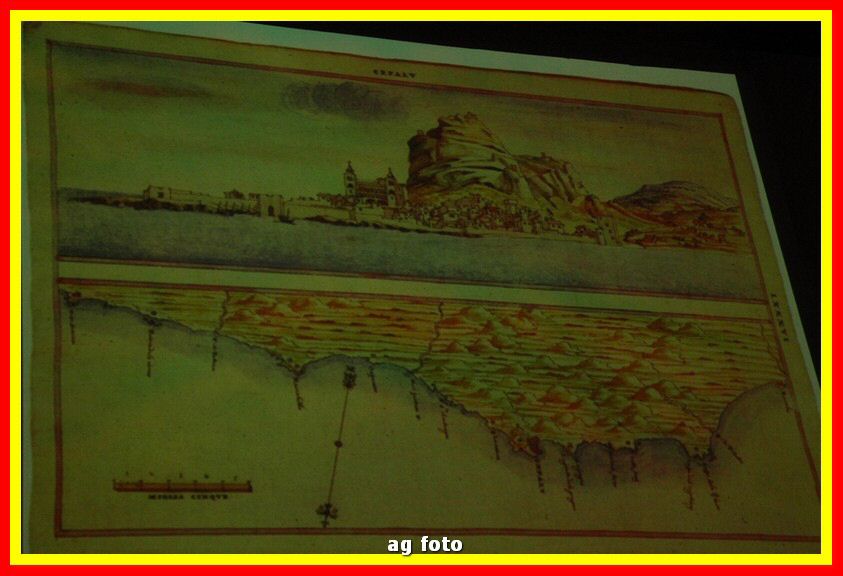
|
|
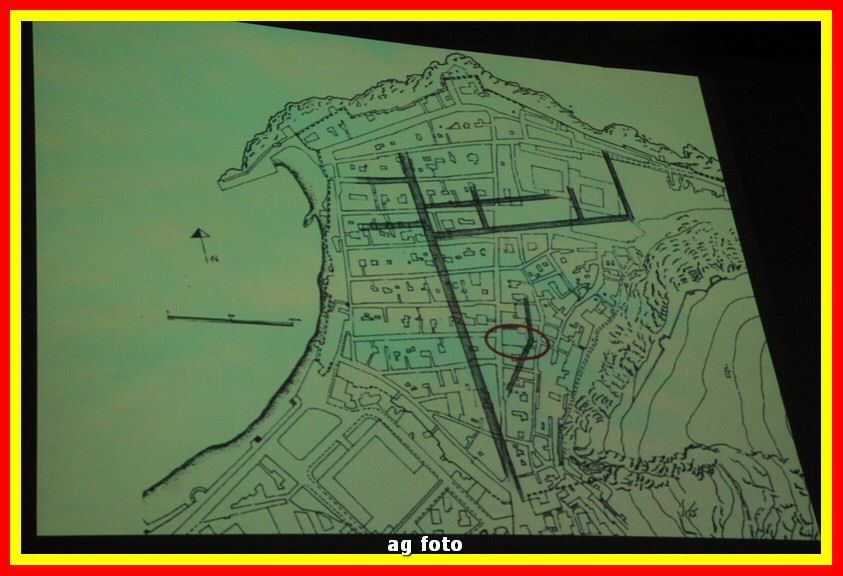
|
|

|
|
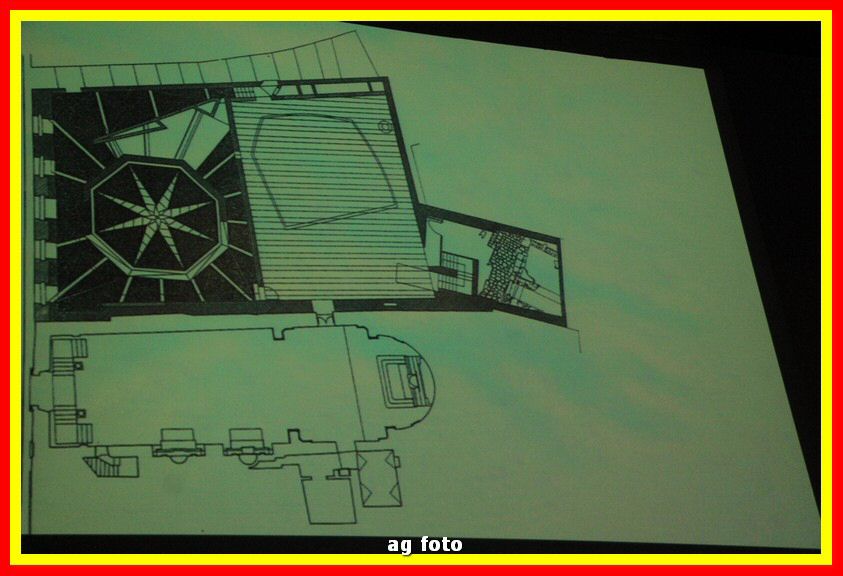
|
|
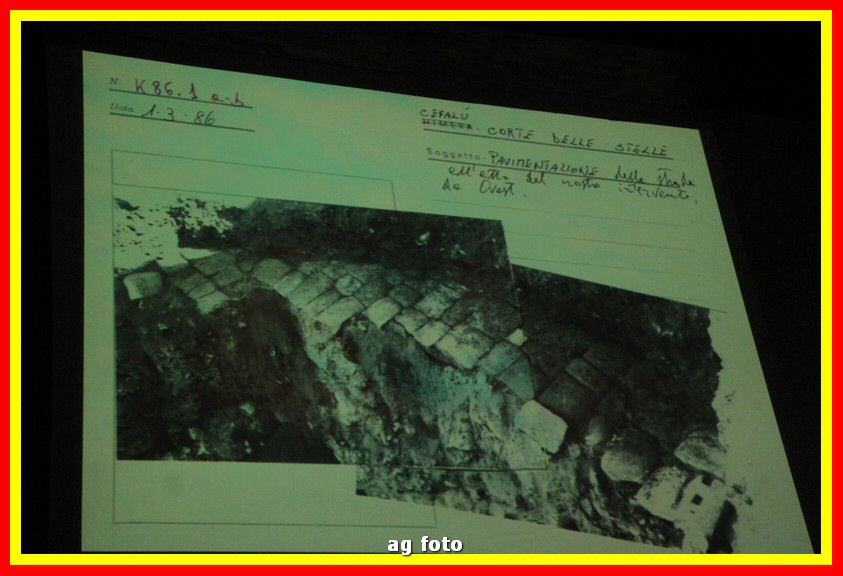
|
|

|
|
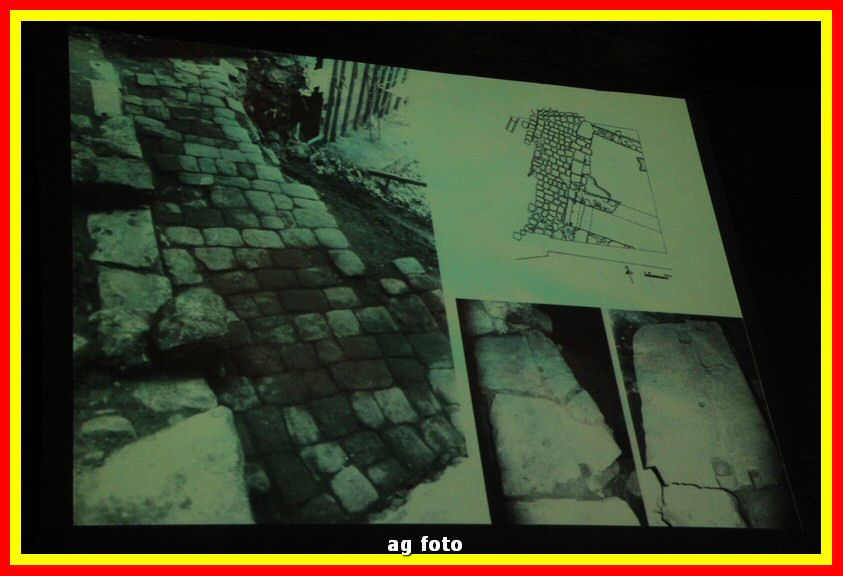
|
|
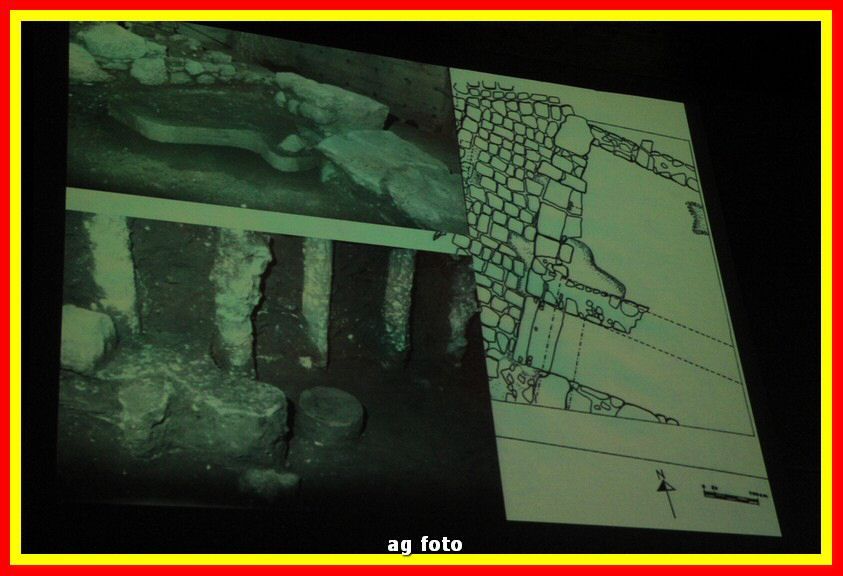
|
|
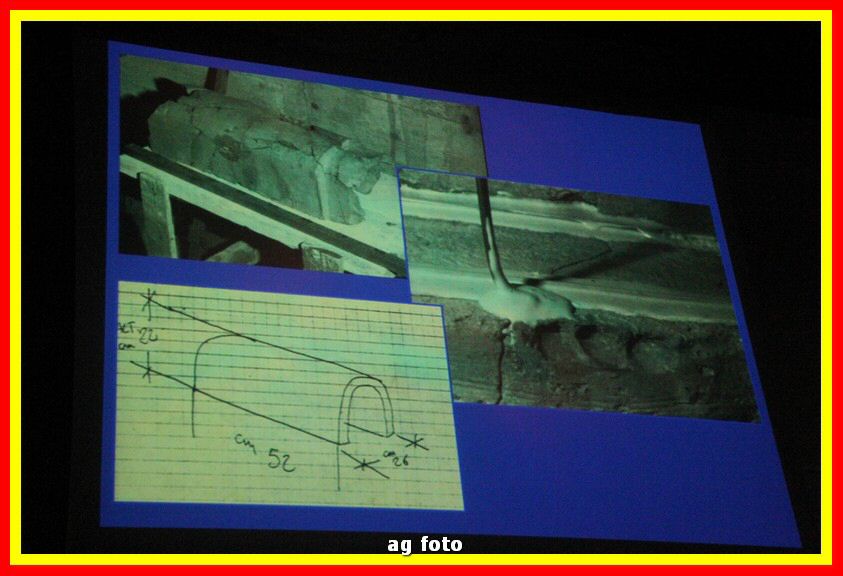
|
|

|
|
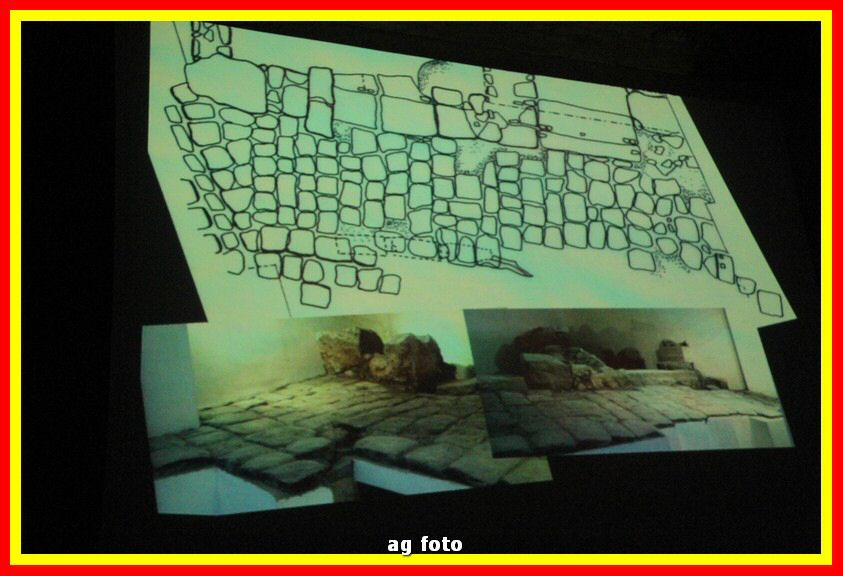
|
|
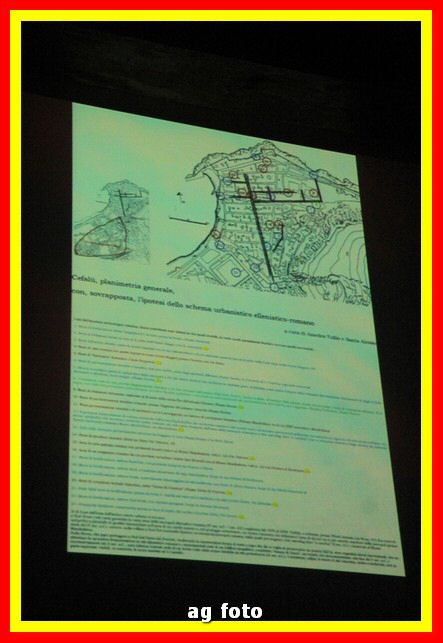
|
|

|
|

|
|

|
|
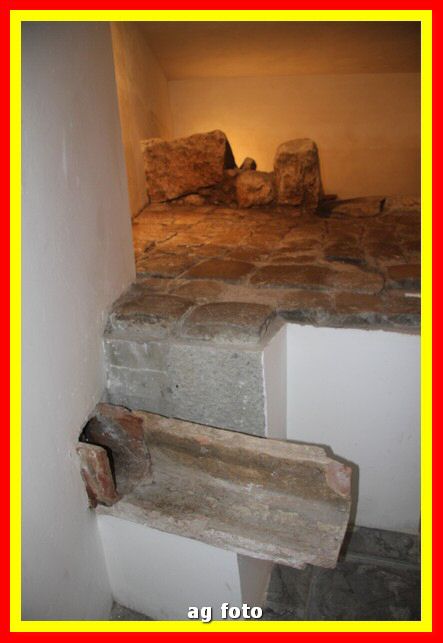
|
|

|
|

|
|

|
|
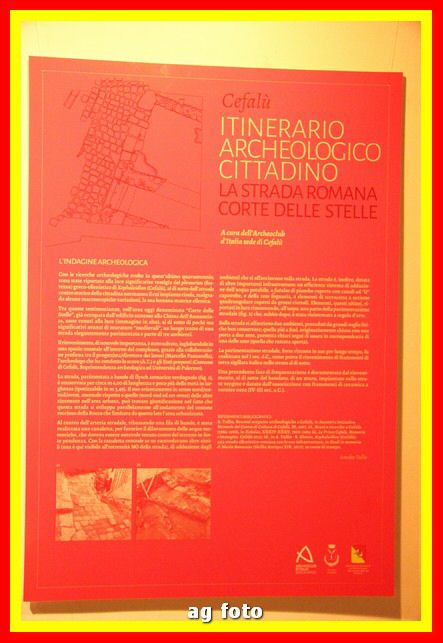
|
|
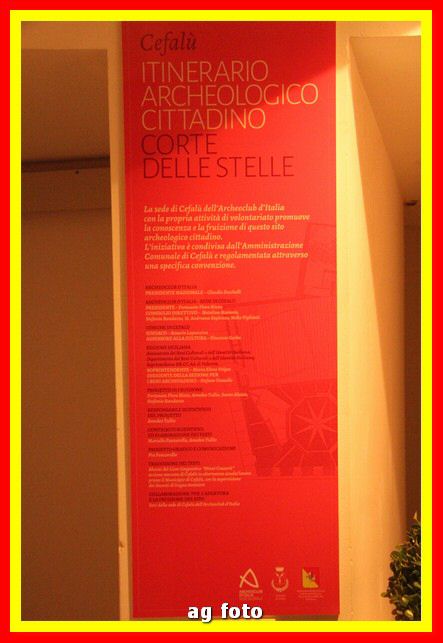
|
|
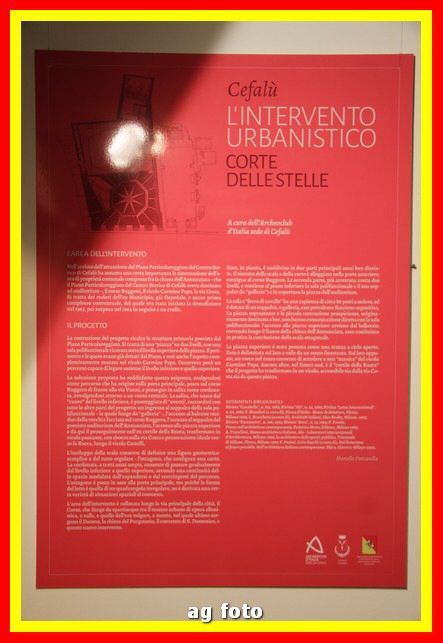
|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|
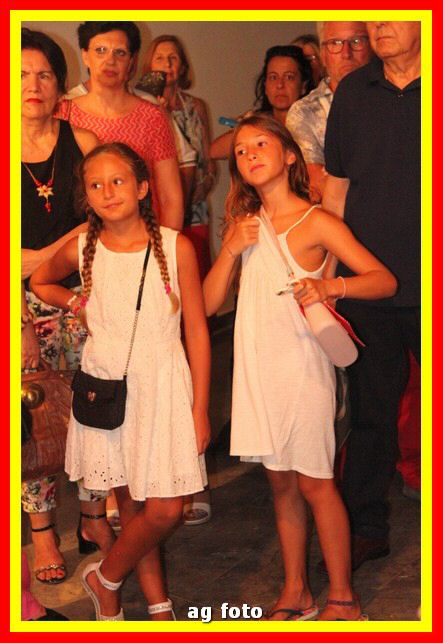
|
|

|
|

|
|
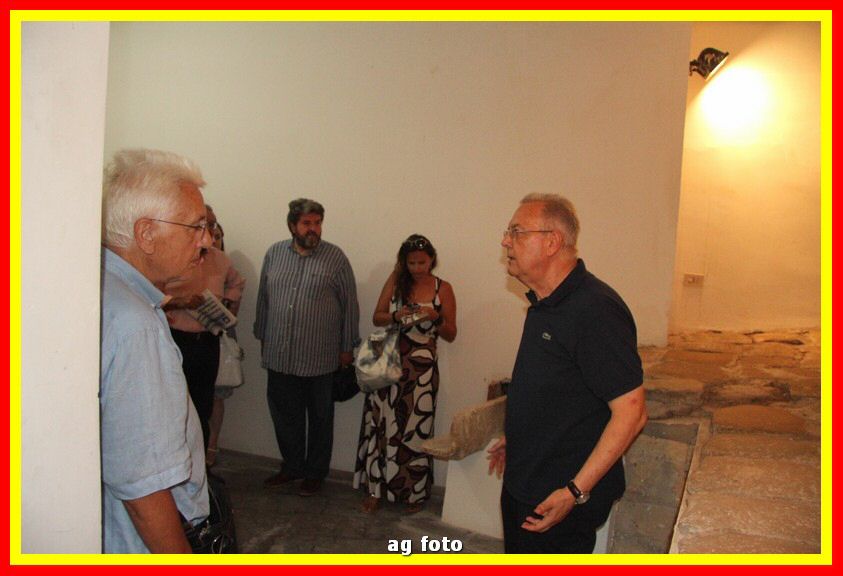
|
|

|
|

|
|
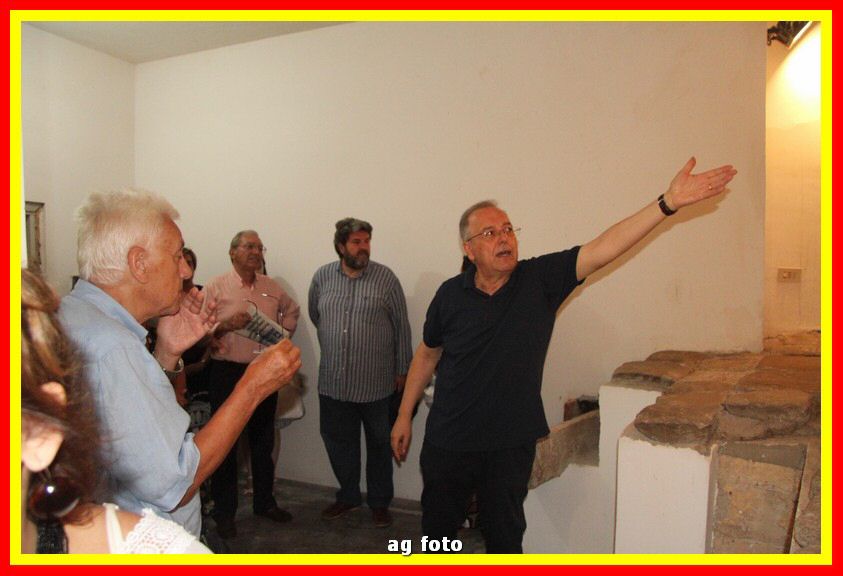
|
|

|
|
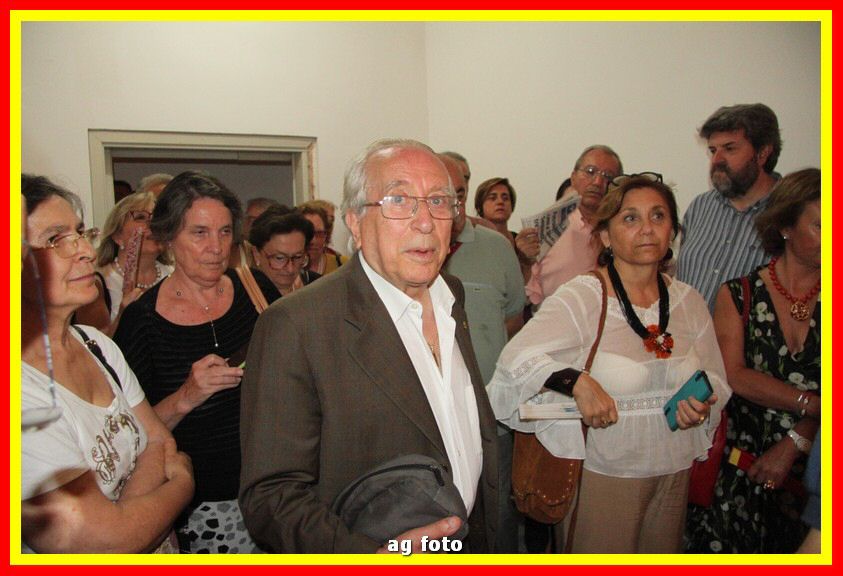
|
|
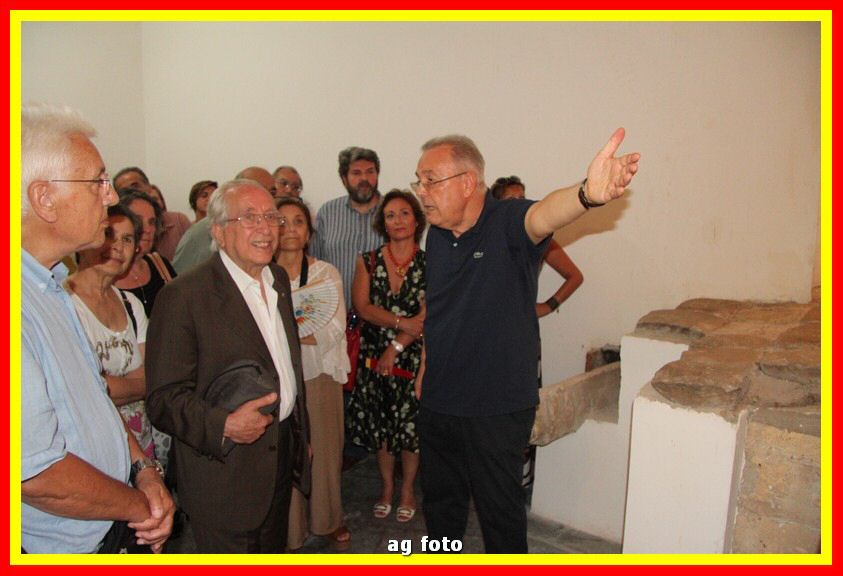
|
|
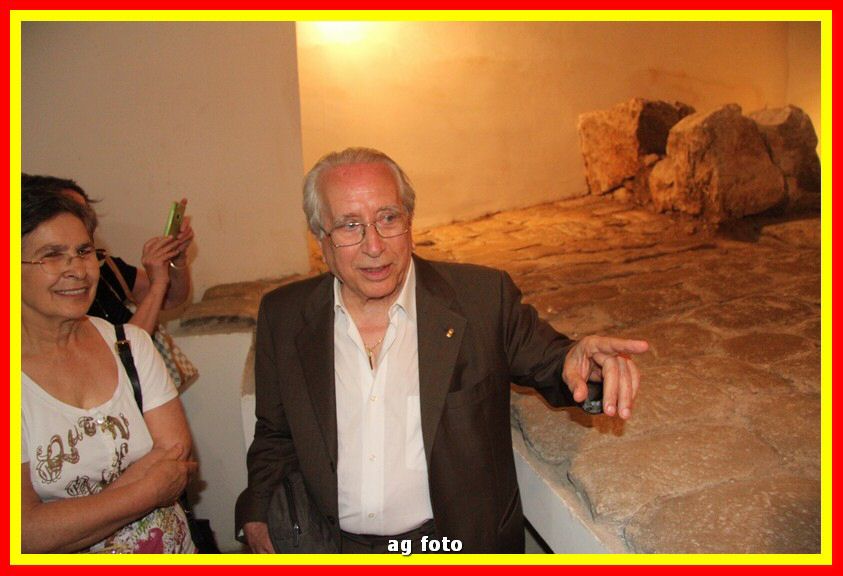
|
|

|
|
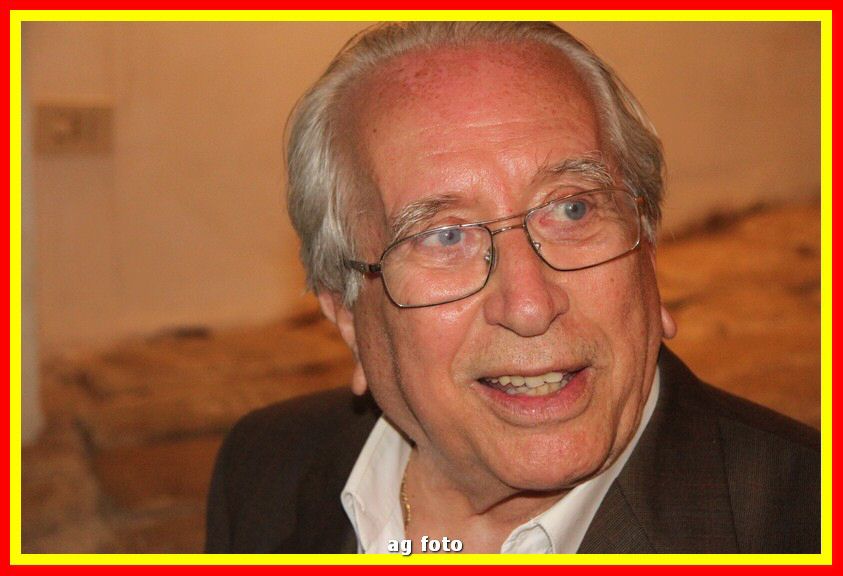
|
|
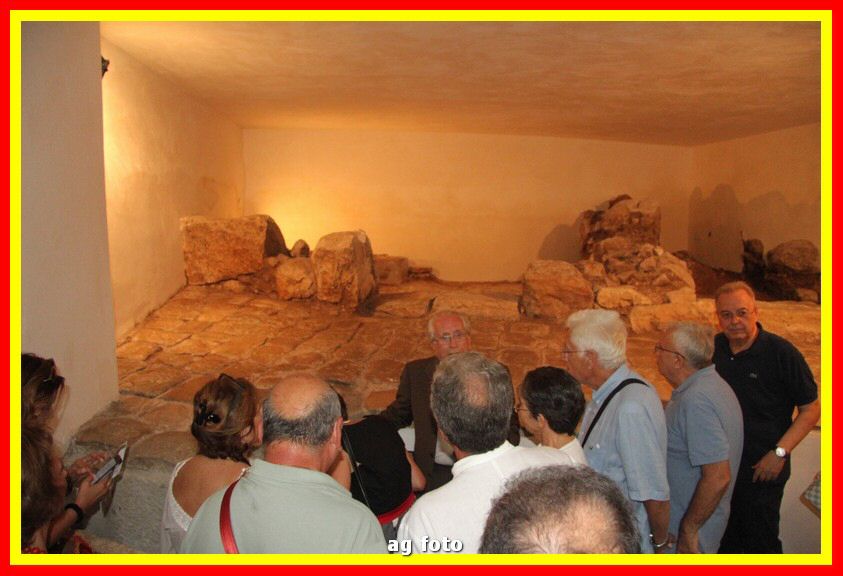
|
|
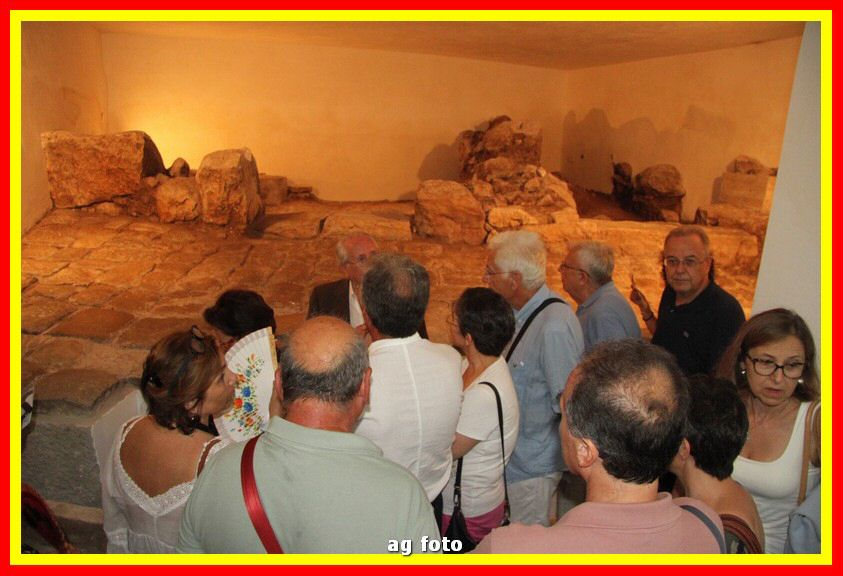
|
|
LA CORTE DELLE STELLE
di Marcello Panzarella
L'area dell'intervento
Nell'ambito dell'attuazione del Piano Particolareggiato del Centro
Storico di Cefalù ha assunto una certa importanza la sistemazione dell'area di
proprietà comunale compresa fra la chiesa dell'Annunziata – che il Piano Particolareggiato
del Centro Storico di Cefalù aveva destinato ad auditorium –, il corso Ruggero,
il vicolo Carmine Papa, la via Costa.
Si tratta dei ruderi dell'ex Municipio, già Ospedale, e ancor prima
complesso conventuale, del quale era stata iniziata la demolizione nel 1963,
poi sospesa nel 1964 in seguito a un crollo.
Il progetto
La costruzione del progetto ricalca la struttura primaria prevista dal
Piano Particolareggiato. Si tratta di una "piazza" su due livelli,
con una sala polifunzionale ricavata sotto il livello superiore della piazza. Il
perimetro e le quote erano già dettati dal Piano, e così anche l'aspetto
complessivamente murato sul vicolo Carmine Papa. Occorreva però un percorso capace
di legare assieme il livello inferiore e quello superiore.
La soluzione proposta ha soddisfatto questa esigenza, svolgendosi come
percorso che ha origine sulla porta principale, posta sul corso Ruggero di
fronte alla via Vanni, e prosegue in salita come cordonata, avvolgendosi attorno
a un vuoto centrale. La salita, che nasce dal "cuore" del livello
inferiore, è punteggiata di "eventi', raccordati con tutte le altre parti
del progetto: un ingresso al soppalco della sala polifunzionale – la quale
funge da "galleria" -, l'accesso al balcone residuo della vecchia
facciata sul corso Ruggero, l'accesso al soppalco del previsto auditorium
dell'Annunziata, l'accesso alla piazza superiore e da qui il proseguimento
nell'ex cortile della Ruota, trasformato in vicolo passante, con sbocco sulla
via Costa e prosecuzione ideale verso la Rocca, lungo il vicolo Castelli.
L'inviluppo della scala consente di definire una figura geometrica
semplice e del tutto regolare - l'ottagono, che
configura una corte. La cordonata, a tratti assai ampia, consente di passare
gradualmente dal livello inferiore a quello superiore, secondo una continuità
dello spazio modulata dall'espandersi o dal restringersi del percorso.
L'ottagono è posto in asse alla porta principale, ma poiché la forma del lotto è
quella di un quadrangolo irregolare, ne è derivata una certa varietà di
situazioni spaziali al contorno.
L'area dell'intervento è
collocata lungo la via principale della città, il Corso, che funge da
spartiacque tra il tessuto urbano di epoca ellenistica, a valle, e quello
dell'era volgare, a monte, nel quale ultimo sorgono il Duomo, la chiesa del
Purgatorio, il convento di S. Domenico, e questo nuovo intervento.
Esso, in pianta, è
suddiviso in due parti principali assai ben distinte. Il sistema della
scala e della corte è alloggiato nella parte anteriore, contigua al corso
Ruggero. La seconda parte, più arretrata, conta due livelli, e contiene al
piano inferiore la sala polifunzionale e il suo soppalco (la
"galleria") e in copertura la piazza dell'auditorium.
La sala a "ferro di cavallo" ha
una capienza di circa 80 posti a sedere, ed è dotata di un soppalco, o
galleria, con prevalente funzione espositiva.
La piazza soprastante e la piccola costruzione prospiciente, originariamente
destinata a bar, non hanno comunicazione diretta con la sala polifunzionale: l'accesso
alla piazza superiore avviene dal ballatoio: correndo lungo il fianco della
chiesa dell'Annunziata, esso costituisce in pratica la conclusione della scala
ottagonale.
La piazza superiore è stata pensata come una stanza a cielo aperto.
Essa è delimitata sul lato a valle da un muro finestrato. Sul lato opposto, un
varco nel muro consente di accedere a una "manica" del vicolo Carmine
Papa. Ancora oltre, sul fianco sud, è il "cortile della Ruota" che il
progetto ha trasformato in un vicolo, accessibile sia dalla via Costa sia da
questa piazza.
Ritrovamento archeologico
Nel corso dei lavori si è rinvenuto, a una quota intermedia, un brano
notevole di tessuto urbano, ambienti e via, risalente al I sec. d.C., con
sostrati ancora più antichi. Il reperto è stato mantenuto in situ, all’interno
di una sala archeologica perfettamente agibile, la cui realizzazione ha però
comportato modifiche consistenti al progetto e alla struttura portante prevista
in origine.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
- rivista Casabella, n. 515,
1985;
- rivista AU, n. 34, 1989;
- rivista Lotus international,
n. 62, 1989;
- F. Nuvolari (a cura di),
Piazze d’Italia - Nuove Architetture, Electa, Milano 1992;
- L. Scacchetti (a cura di),
Architetti italiani,Idea Books, Milano, 1992;
- Parametro, n. 196, 1993;
- rivista Area, n. 13, 1993;
- P. Favole, Piazze
nell’architettura contemporanea, Federico Motta Editore, Milano 1995;
A. Franchini, Nuova
architettura italiana, Ala - Laboratori internazionali
d'Architettura, Milano 1996;
- Le architetture dello spazio
pubblico, Triennale di Milano, Electa, Milano 1997;
- F. Purini, Livio Sacchi (a
cura di), Dal Futurismo al futuro possibile.
Nell’architettura italiana
contemporanea. Skira, Ginevra-Milano 2002.
|
|
Corte
delle Stelle, la strada romana. di
Amedeo Tullio
Con le
ricerche archeologiche svolte in quest’ultimo quarantennio, sono state
riportate alla luce significative vestigia del phrourion (fortezza) greco-ellenistico di Kephaloidion (Cefalù), al di sotto dell’attuale centro storico
della cittadina normanna il cui impianto rivela, malgrado alcune macroscopiche
variazioni, la sua lontana matrice ellenica.
Tra queste
testimonianze, nell’area oggi denominata “Corte delle Stelle”, già occupata
dall’edificio annesso alla Chiesa dell’Annunziata, sono venuti alla luce (fig. 1), al di sotto di pochi ma
significativi avanzi di murature “medievali”, un lungo tratto di una strada elegantemente
pavimentata e parte di tre ambienti.
Il rinvenimento,
di notevole importanza, è stato salvato, inglobandolo in uno spazio museale
all’interno del complesso, grazie alla collaborazione proficua tra il
progettista/direttore dei lavori (Marcello Panzarella), l’archeologo che ha
condotto lo scavo (A.T.) e gli Enti preposti (Comune di Cefalù, Soprintendenza
archeologica ed Università di Palermo).
La strada, pavimentata
a basole di flysch arenacico verdognolo (fig.
2), è conservata per circa m 6,00 di lunghezza e poco più della metà in
larghezza (ipotizzabile in m 3,49). Il suo orientamento in senso nord/est-sud/ovest,
anomalo rispetto a quello (nord-sud ed est-ovest) delle altre rinvenute
nell’area urbana, può trovare giustificazione nel fatto che questa strada si
sviluppa parallelamente all’andamento del costone roccioso della Rocca che
limitava da questo lato l’area urbanizzata
Al centro
dell’arteria stradale, ribassando una fila di basole, è stata realizzata una
canaletta, per favorire il dilavamento delle acque meteoriche che doveva essere
notevole tenuto conto del terreno in forte pendenza. Con la canaletta centrale
se ne raccordavano altre simili (una è qui visibile all’estremità NO della
strada), di adduzione dagli ambienti che si affacciavano sulla strada. La strada
è, inoltre, dotata di altre importanti infrastrutture: un efficiente sistema di
adduzione dell’acqua potabile, a fistulae di piombo coperte con canali
ad “U” capovolte, e della rete fognaria, a elementi di terracotta a sezione
quadrangolare coperti da grossi ciottoli. Elementi, questi ultimi, riportati in
luce rimuovendo, all’uopo, una parte della pavimentazione stradale (fig. 3) che, subito dopo, è stata
risistemata a regola d’arte.
Sulla strada si affacciano due ambienti, preceduti da grandi soglie litiche
ben conservate; quella più a Sud, originariamente chiusa con una porta a due
ante, presenta chiari segni di usura in corrispondenza di una delle ante
(quella che restava aperta).
La pavimentazione stradale, forse rimasta in uso per lungo tempo, fu
realizzata nel I sec. d.C., come prova il rinvenimento di frammenti di terra
sigillata italica nello strato al di sotto.
Una precedente fase di frequentazione è documentata dal rinvenimento, al di
sotto del basolato, di un muro, impiantato sullo strato vergine e datato
dall’associazione con frammenti di ceramica a vernice nera (IV-III sec. a.C.).
Riferimenti bibliografici: A. Tullio,
Recenti scoperte archeologiche a Cefalù, in Incontri
e Iniziative. Memorie del Centro di Cultura di Cefalù, IV,1987; Id., Scavi e ricerche a Cefalù
(1984-1988), in Kokalos,
XXXIV-XXXV,1988-1989; Id., Le Prime
Cefalù. Memoria e immagini, Cefalù 2015; Id., in A. Tullio - S. Aloisio, Kephaloidion
(Cefalù): una strada ellenistico-romana con le sue infrastrutture, in Studi in memoria di Nicola Bonacasa (Sicilia
Antiqua XIV, 2017), in corso di stampa.
|
|
|
|
|